
Mi facevo chiamare Silvio D’Arzo
Mi facevo chiamare Silvio D’Arzo
Nasco a Reggio Emilia il 6 febbraio del 1920, da Rosalinda Comparoni, che vive in uno stanzone enorme di via Aschieri, al numero 4, manda avanti una vita anonima tra mille mestieri, cartomante e bigliettaia di cinema, lasciata da un padre che non conobbi e che mai volli sapere chi fosse. Non ho avuto molto dalla vita, forse solo la soddisfazione di piacere a Emilio Cecchi, ché quando scrivo Casa d’altri penso soltanto a lui, è il mio ideale di lettore, al punto che la sua risposta diventa la cosa più importante che possa capitarmi. Siamo nel 1947, piena estate della Seconda Guerra Mondiale ma io penso alle sorti del racconto, umile provinciale quale sono, prendo carta e penna e mi firmo, ringraziando, Ezio Comparoni, una delle poche volte che uso il vero nome, ché i primi tempi mi faccio chiamare Raffaele, quando con Carabba pubblico sette racconti in una raccolta intitolata Maschere. Luci e penombre è il mio secondo libro, poesie giovanili, ci metto tutto il mio sapere, le buone letture da Verga a D’Annunzio, passando per il Dostoevskij di Delitto e castigo. Frequento il ginnasio allo Spallanzani di Reggio, ma son precoce, non posso far le cose che fan tutti, così mi preparo con Giuseppe Zonta, prendo la maturità classica a sedici anni, da privatista, a Pavia. Laurea in Lettere a Bologna, è il 1941, ventun anni, ditemi se è poco, discuto una tesi sui dialetti reggiani con il professor Bottiglioni, glottologia, la mia passione, intanto insegno in qualche professionale e impartisco lezioni per aiutare a casa. Insegnare mi piace. I ragazzi mi seguono. E io racconto storie, collego Manzoni e Stevenson senza alcun problema, il romanzo è tale in ogni sfaccettatura, sia L’isola del tesoro che I promessi sposi. Scrivo tanto, butto e riscrivo, comincio racconti, abbozzo romanzi, pubblico su riviste storie del mistero, di vita quotidiana, di contrabbandieri e bambini, di sogni e campagne, paesaggi emiliani e shakespeariani, senza soluzione di continuità. Pubblicheranno tutto molto dopo, io non ci sarò più, solo All’insegna del buon corsiero vedo stampato da Vallecchi, nel 1942, immatura prova che narra di locande e carrozze, di uomini e donne che vivono nel millesettecento. Eppure piace, c’è chi lo definisce opera originale d’un certo Silvio D’Arzo, di padre ignoto, pure se si chiamava Pietro Comparoni, in vita non lo volli mai sapere, preferivo D’Arzo tra i tanti nomi di fantasia inventati, ché ricordava la mia terra, Arz, Reggio in dialetto, come arzàn sta per reggiano. Non faccio prosa d’arte come Cecchi, non la so fare, preferisco una cadenza metrica per quel che scrivo, metafore nuove, un suono preciso alle parole. Vivo un’Italia fascista e provinciale, amo gli autori inglesi e americani, cerco rifugio nelle lettere a tutta la tristezza che c’è intorno. Devo fare il servizio militare, soldato a Canzo, vicino a Como, poi ufficiale ad Avellino, quando Badoglio firma l’armistizio mi trovo a Barletta, per fortuna non parto per il fronte Egeo. Mi catturano i tedeschi, viaggio un giorno e una notte insieme a tanti disperati, poi fuggo quando il treno si ferma a Francavilla, mi rifugio in casa di contadini che mi danno asilo. Finirà questa guerra, mi dico. Torneremo alle cose d’un tempo. E infatti un giorno rivedo la mia Reggio, mi tuffo per dimenticare nei libri che avevo lasciato ad aspettare, da Swift a Defoe, Dickens e Carroll, i racconti di Perrault segnano i miei giorni. Vorrei che Vallecchi pubblicasse Bambi, subito dopo la morte del suo autore, ma non mi ascolta, leggo di tutto, romanzi d’avventura, cose fantastiche che profumano di sogni. Alice, Gulliver, Robinson, Oliwer Twist e il mio caro Lazzarillo, piccolo iberico accattone. Scrivo favole anch’io, non posso farne a meno, vien fuori Penny Wirton e sua madre, dove invento un bimbo che fugge di casa, deluso per aver scoperto che il padre fa il sellaio, ma poi ritorna per star accanto a sua madre. Peccato che son già morto quando qualcuno scrive che è il libro per ragazzi più bello mai scritto in italiano, dopo Pinocchio. Non mi fermo, arriva Tobby in prigione, tra castori e pellicce, poi Il pinguino senza frac, forse il racconto più fantastico. Una storia così, invece, racconta un insegnante che combatte contro un direttore burbero e poco comprensivo. Gec è la storia d’un bambino che non vuol nascere con la camicia. Finita la guerra c’è posto e tempo anche per l’amore, ché Ada Gorini è la donna della mia vita, pittrice di sentimenti e del mio cuore. Non son compagnone, ho gli amici di sempre con cui passo le sere tra chiacchiere di lettere e passioni. Scrivo tanto, correggo, aiuto studenti, mi fingo traduttore d’un Andrew Mackenzie che non è mai esistito, leggo Edgar Lee Masters, scrivo poesie sepolcrali, proprio come lui. Il Contemporaneo e Paragone son le riviste dove scrivo per dar vita al mio sogno angloamericano, la letteratura che più amo, da Hemingway a Kipling, passando per James, senza dimenticare il buon Villon che era francese. Contea inglese sarà la mia scrittura fatta di frammenti di passato, ricordi antichi pescati nel mio prato. 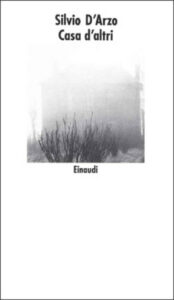 Ma il mio capolavoro è Casa d’altri, non foss’altro per quel che scrisse Cecchi, uno che amava Conrad e lo capiva, mica poco. Sarei dovuto diventar qualcuno, disse il vecchio poeta. Almeno nelle lettere, sia chiaro. Ma la vita mica sempre fa le cose come dovrebbe farle. Anzi è la morte che spesso ci mette lo zampino. Bompiani chiede tempo per pubblicare il libro, Einaudi per mano di Pavese scrive che la novella è esile, che manca qualche cosa, che bisogna rivedere. L’illustrazione italiana pubblica uno stralcio, lo intitola Io prete e la vecchia Zelinda, scritto da un tal Sandro Nedi, che poi son io, sotto falso nome. Il titolo che amo non va bene, Qualcosa succede anche a Montelice, troppo lungo e poco evocativo; lo spedisco a Vallecchi, con il parere positivo del buon Cecchi, vorrei provare anche con Guanda, ma il primo lo rifiuta e col secondo non faccio in tempo a preparar la busta. Il 30 gennaio del 1952, una maledetta leucemia brucia i miei sogni, tu pensa che ne avevo ancora tanti a soli trentadue anni; in futuro quella malattia si potrà curare, adesso no, si può solo morire. Clinica Villa Ida, Reggio Emilia, finisce il mio tempo con la vita, mia madre accanto che mi dà la mano, lei sopravvive. Adesso siamo insieme al cimitero, mi ha raggiunto nel 1964, ancora la rammento quando veniva qui sulla mia tomba, portava fiori, un po’ si commuoveva, raccontava del mio libro uscito, che per Montale era un racconto perfetto, l’aveva scritto sul Corriere della Sera. Casa d’altri vive dopo la mia morte, il più bel racconto del Novecento italiano, dicono, cinquanta pagine ricche d’emozione, scritte con stile da poeta. Io non lo so mica se è il racconto più bello che ci sia, so che ci ho messo tutta la passione di cui potevo andare ancora fiero, dopo aver letto Puskin e Lermontov, Kafka e Hemingway, Checov e Kleist. Merito di Attilio Bertolucci, grande poeta, se il mio racconto esce su Botteghe Oscure, poi ci mette bocca anche Bassani e Sansoni lo pubblica in collana. La storia racconta proprio poco, c’è tutto lo sgomento di quel prete che si vede narrare da una donna di paese il desiderio di togliersi dal mondo, di suicidarsi, perché ha smarrito il senso della vita. Argomento difficile, storia di sguardi e sensazioni, di descrizioni, di paesaggi montani e collinari, di colloqui cupi, quasi in penombra, tra un prete e una donna di campagna. In quel racconto c’è tutta la mia terra, ci sono i calanchi e le creste dei monti, i boschi e i sentieri, le erbe dei pascoli, l’aria viola al tramonto, il color ruggine vecchia che si stempera nei sogni. Ci sono i corpi avvolti in chiaroscuro di turpi confessioni, i tramonti, l’estate che finisce, cede al dolente autunno, dipinto tra tenui colori, descritto in vuote giornate d’un tempo che non avanza. Il mio stile è un colto italiano tuffato in dialetto, arcaismi e parole d’un tempo, il metro è quello della mia poesia prediletta, percussioni sonore e rimpianti, parole che cadono lente sulla pagina bianca, poi un punto, una virgola, un lieve sospiro che rende la frase cadenza e la fa poesia. Non son neorealista e neppure verista, non è prosa d’arte la mia, è cosa diversa, la fantasia che corre sfrenata per le strade fiorite del mio Appennino, dove invento cose mai accadute, usanze e costumi che vengon da lidi lontani. Il mio Casa d’altri è canzone melodica scritta da un narratore che si compiace di come scrive le cose, non tanto di quello che scrive, un allarme lirico, una frase in attesa che ne aggiunga un’altra d’identico suono. E se guardo la luna per me è lucida e fresca come l’avessero tolta da un secchio, come la placida sera si diffonde nel vergine incanto lunare, a volte gelata e smorta, gocciolante come una moneta caduta in una vasca. La scenografia del mio paese è fatta d’un torrente che scorre, immutabile come le montagne d’intorno, fissato in un eterno presente, unica certezza possibile, come la morte, scelta dalla mia Zelinda come quiete finale, rifugio alle tempeste del mondo. Zelinda è il ricordo di mia madre Rosalinda, così come il paese immaginario è il suo paese, quel Cerreto dell’Alpi dove andavo sempre a passar l’estate da bambino, tra Reggio e Spezia, in mezzo all’Appennino. Il dolore di mia madre sarà simile al dolore di Zelinda, per la mia morte inattesa, pure lei attenderà la morte per trovare finalmente la sua pace. Termino il racconto, che scrivo e riscrivo troppe volte, incerto se spiegare la fine che farà Zelinda, infine decido di lasciare in sospeso, sarà il lettore a decidere gli eventi. Calo il sipario sulla morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la Melida li cuce dentro il lenzuolo ed io li porto al cimitero di monte, e i bambini che per l’intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli … Tutto profuma di morte, in fondo. E io credo solo nei libri che scrivo. E li vivo. Non sono James Cain. Non mi è dato percorrere strade americane in automobile. Resto nel mio paese. Attendo risposte da un innocente vecchietto autorevole, mezza bandiera del tempo che fu, che mi prese a benvolere, chissà poi perché, senza immaginare che io ero, a dir poco, due o tre volte più vecchio di lui. La mia esistenza provvisoria, come quella di tutti, mi presenta il conto troppo presto, mentre scrivo i racconti del dopoguerra, il romanzo Nostro lunedì (solo la prefazione resta), storie di militari sbandati dopo l’otto settembre … Il mondo non è casa tua, nel mondo ci stiamo a dozzina, si dice in Emilia. E la mia parte in affitto in breve tempo è scaduta, purtroppo.
Ma il mio capolavoro è Casa d’altri, non foss’altro per quel che scrisse Cecchi, uno che amava Conrad e lo capiva, mica poco. Sarei dovuto diventar qualcuno, disse il vecchio poeta. Almeno nelle lettere, sia chiaro. Ma la vita mica sempre fa le cose come dovrebbe farle. Anzi è la morte che spesso ci mette lo zampino. Bompiani chiede tempo per pubblicare il libro, Einaudi per mano di Pavese scrive che la novella è esile, che manca qualche cosa, che bisogna rivedere. L’illustrazione italiana pubblica uno stralcio, lo intitola Io prete e la vecchia Zelinda, scritto da un tal Sandro Nedi, che poi son io, sotto falso nome. Il titolo che amo non va bene, Qualcosa succede anche a Montelice, troppo lungo e poco evocativo; lo spedisco a Vallecchi, con il parere positivo del buon Cecchi, vorrei provare anche con Guanda, ma il primo lo rifiuta e col secondo non faccio in tempo a preparar la busta. Il 30 gennaio del 1952, una maledetta leucemia brucia i miei sogni, tu pensa che ne avevo ancora tanti a soli trentadue anni; in futuro quella malattia si potrà curare, adesso no, si può solo morire. Clinica Villa Ida, Reggio Emilia, finisce il mio tempo con la vita, mia madre accanto che mi dà la mano, lei sopravvive. Adesso siamo insieme al cimitero, mi ha raggiunto nel 1964, ancora la rammento quando veniva qui sulla mia tomba, portava fiori, un po’ si commuoveva, raccontava del mio libro uscito, che per Montale era un racconto perfetto, l’aveva scritto sul Corriere della Sera. Casa d’altri vive dopo la mia morte, il più bel racconto del Novecento italiano, dicono, cinquanta pagine ricche d’emozione, scritte con stile da poeta. Io non lo so mica se è il racconto più bello che ci sia, so che ci ho messo tutta la passione di cui potevo andare ancora fiero, dopo aver letto Puskin e Lermontov, Kafka e Hemingway, Checov e Kleist. Merito di Attilio Bertolucci, grande poeta, se il mio racconto esce su Botteghe Oscure, poi ci mette bocca anche Bassani e Sansoni lo pubblica in collana. La storia racconta proprio poco, c’è tutto lo sgomento di quel prete che si vede narrare da una donna di paese il desiderio di togliersi dal mondo, di suicidarsi, perché ha smarrito il senso della vita. Argomento difficile, storia di sguardi e sensazioni, di descrizioni, di paesaggi montani e collinari, di colloqui cupi, quasi in penombra, tra un prete e una donna di campagna. In quel racconto c’è tutta la mia terra, ci sono i calanchi e le creste dei monti, i boschi e i sentieri, le erbe dei pascoli, l’aria viola al tramonto, il color ruggine vecchia che si stempera nei sogni. Ci sono i corpi avvolti in chiaroscuro di turpi confessioni, i tramonti, l’estate che finisce, cede al dolente autunno, dipinto tra tenui colori, descritto in vuote giornate d’un tempo che non avanza. Il mio stile è un colto italiano tuffato in dialetto, arcaismi e parole d’un tempo, il metro è quello della mia poesia prediletta, percussioni sonore e rimpianti, parole che cadono lente sulla pagina bianca, poi un punto, una virgola, un lieve sospiro che rende la frase cadenza e la fa poesia. Non son neorealista e neppure verista, non è prosa d’arte la mia, è cosa diversa, la fantasia che corre sfrenata per le strade fiorite del mio Appennino, dove invento cose mai accadute, usanze e costumi che vengon da lidi lontani. Il mio Casa d’altri è canzone melodica scritta da un narratore che si compiace di come scrive le cose, non tanto di quello che scrive, un allarme lirico, una frase in attesa che ne aggiunga un’altra d’identico suono. E se guardo la luna per me è lucida e fresca come l’avessero tolta da un secchio, come la placida sera si diffonde nel vergine incanto lunare, a volte gelata e smorta, gocciolante come una moneta caduta in una vasca. La scenografia del mio paese è fatta d’un torrente che scorre, immutabile come le montagne d’intorno, fissato in un eterno presente, unica certezza possibile, come la morte, scelta dalla mia Zelinda come quiete finale, rifugio alle tempeste del mondo. Zelinda è il ricordo di mia madre Rosalinda, così come il paese immaginario è il suo paese, quel Cerreto dell’Alpi dove andavo sempre a passar l’estate da bambino, tra Reggio e Spezia, in mezzo all’Appennino. Il dolore di mia madre sarà simile al dolore di Zelinda, per la mia morte inattesa, pure lei attenderà la morte per trovare finalmente la sua pace. Termino il racconto, che scrivo e riscrivo troppe volte, incerto se spiegare la fine che farà Zelinda, infine decido di lasciare in sospeso, sarà il lettore a decidere gli eventi. Calo il sipario sulla morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la Melida li cuce dentro il lenzuolo ed io li porto al cimitero di monte, e i bambini che per l’intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli … Tutto profuma di morte, in fondo. E io credo solo nei libri che scrivo. E li vivo. Non sono James Cain. Non mi è dato percorrere strade americane in automobile. Resto nel mio paese. Attendo risposte da un innocente vecchietto autorevole, mezza bandiera del tempo che fu, che mi prese a benvolere, chissà poi perché, senza immaginare che io ero, a dir poco, due o tre volte più vecchio di lui. La mia esistenza provvisoria, come quella di tutti, mi presenta il conto troppo presto, mentre scrivo i racconti del dopoguerra, il romanzo Nostro lunedì (solo la prefazione resta), storie di militari sbandati dopo l’otto settembre … Il mondo non è casa tua, nel mondo ci stiamo a dozzina, si dice in Emilia. E la mia parte in affitto in breve tempo è scaduta, purtroppo.
Gordiano Lupi
Commenti recenti